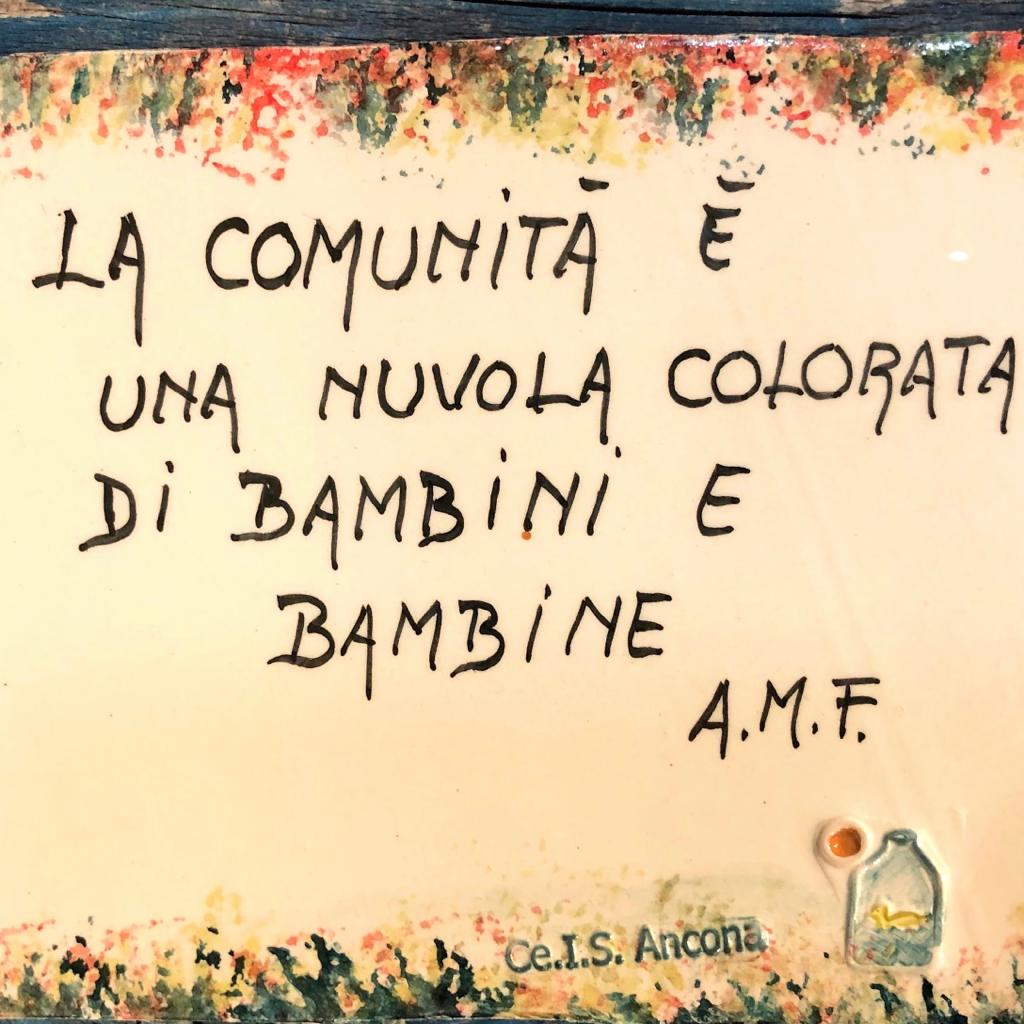Diversi articoli sono apparsi questa estate sul tema degli educatori professionali, se la laurea debba essere obbligatoria o meno e sul personale introvabile. Ma chi è l’educatore/educatrice professionale e quali competenze dovrebbe avere? Proviamo a riflettere, mettendo al centro, ad esempio, i diritti dei bambini e degli adolescenti ospiti delle comunità: che colloquio fareste per assumere un educatore o un’educatrice? Proviamo a crearne uno ipotetico, in un’ottica relazionale, e ispirato alla teoria dell’attaccamento.
Cosa chiedere allora? A me verrebbero in mente diverse domande e, dopo aver chiesto semplicemente di presentarsi e di parlare un po’ di sé, delle motivazioni che sono alla base della sua scelta di lavorare in comunità, quando c’è un clima disteso e più accogliente e pronto per una comunicazione più profonda, chiederei la disponibilità a parlare un po’ del passato, dell’infanzia e delle relazioni significative di quel primissimo periodo della vita che segna profondamente il nostro modo di sentirci e di sentire l’altro e il mondo nel quale viviamo e tenterei un approccio narrativo che esula da ogni forma di giudizio aprioristico:
Posso chiederle, se vuole parlarmi un po’ dei suoi ricordi più lontani, pensando agli episodi di quel periodo lontano in cui ha chiesto aiuto alla persona o alle persone di cui si fidava di più e che le davano più sicurezza quando si è trovato/a in pericolo o ha avuto paura o semplicemente era ammalato/a o temeva di essere sgridato /a?
Questo primo ingresso nel ricordo apre un mondo inaspettato per chi pensa che educare in comunità riguardi soprattutto gli altri e non se stessi. Al contrario, educare in comunità significa prendere confidenza innanzitutto con sé stessi e con la propria storia di piccole o grandi ingiustizie, di piccole o grandi paure e del come ci si è sentiti in quei momenti di sofferenza e di timore e di come ci siamo sentiti accolti o rifiutati o come è stata minimizzata la nostra domanda di aiuto, lasciandoci nel dubbio di essere sbagliati.
Abbiamo avviato un dialogo con l’altro: tra noi che conversiamo e l’altro che conversa con noi e con sè stesso. E’ un dialogo inatteso tra il passato relazionale e l’attualità: il dialogo più potente in campo educativo.
Continuiamo il nostro colloquio lasciando il tempo di far depositare la portata emotiva di questo vissuto e iniziamo a parlare della quotidianità, di come ci sentiamo nelle routine della vita quotidiana che struttura il setting esterno della comunità, come il dialogo appena attivato sostanzia il setting interno di ogni educatore/educatrice.
Le domande che seguono sono allora più leggere, ma altrettanto importanti, per comprendere se quella persona sta bene nel quotidiano dispiegarsi delle azioni di cura che in ogni casa, inclusa la comunità, si esplicano ogni giorno nel lavare, cucinare, fare i compiti assieme, accompagnarti in macchina nei luoghi della vita; scuola, sport, amici.
Esordiamo con la cucina. Il cibo cura; la primaria relazione di cura è un buon nutrimento, lo sappiamo:
A lei piace cucinare? Che piatti le vengono in mente come suoi punti forti? Chi glieli ha insegnati?
Ora l’altro ci sorride. E’ più facile rispondere. In realtà non lo è affatto per chi non ha sperimentato relazioni primarie di buon nutrimento. Chi sorride, ha buoni ricordi ai quali si aggancia. Sono ricordi così potenti che sono ancora in grado di rassicurare e di far sorridere.
Posso continuare a esplorare la cura ricevuta, o mancante, attraverso altri ricordi, quelli relativi alla scuola, ai compiti scolastici, ai pomeriggi in cui mi cimentavo da solo/a o aiutato/a in qualcosa che mi sembrava troppo complicato da eseguire.
Posso chiederle nel periodo scolastico con chi faceva i compiti il pomeriggio o il sabato e la domenica? E anche con chi giocava e passava il tempo?
Si apre un nuovo scenario. Chi si laurea oggi nelle lauree triennali in Scienze dell’Educazione è poco più che ventenne, nato nel terzo millennio o nel 1999 prevalentemente. Nel terzo millennio e al termine di quello passato molti giovani non hanno avuto accesso a una quotidianità molto condivisa con i loro genitori e il tempo spesso si è saturato nella distanza. Non sono stati molto assieme, non hanno condiviso molti compiti e neppure molto tempo in giochi, passeggiate, attività comuni.
Non è semplice per chi ha poco vissuto l’interazione accudente e rassicurante, sentire e capire come metterla in atto con gli altri. Chi vive in comunità ha necessità di nutrirsi di relazioni accudenti.
Procedo allora nel mio colloquio con poche domande e tanta disponibilità ad accogliere il silenzio e, a volte lo smarrimento dell’altro: “perché mi sta facendo queste domande, cosa c’entrano con il lavoro in comunità? Io sono laureato/a, ho studiato e ho il titolo per farlo.
Vado verso la conclusione e provo a restituire il valore del nostro incontro, anche se in comunità non verrà mai a lavorare:
E’ stato un bell’incontro, la ringrazio. Forse le mie domande l’hanno un po’ turbato/a, si sarà chiesto/a che cosa c’entra la mia vita, il mio passato con il mestiere di educatore. Le rispondo con la passione che ho da sempre per i miei figli come per quelli che non possono vivere in famiglia. Il mestiere dell’educatore è meraviglioso, ma è un mestiere artigianale che ha un solo strumento; la relazione. La relazione ci permette di crescere e di sentirci accolti e amati o di sentirci sbagliati o di sentirci inadeguati ed è sempre la relazione che nel tempo della nostra vita ci dà altre occasioni per sentirci meglio, per riparare le nostre delusioni, i nostri insuccessi, i nostri dubbi. Assieme oggi abbiamo ripercorso il ricordo della sua vita e della sua storia relazionale. Ora è più pronto/a a prendere il testimone: la relazione che accoglie e cura. Ci pensi e se si sente pronto/a, la nostra comunità l’aspetta.
Questa è la traccia del colloquio che vi propongo. Pensateci! Voi come vi comportereste? E’ sufficiente una laurea e quale percorso all’interno di una laurea può aiutare lo studente e la studentessa a diventare un educatore e un’educatrice “sufficientemente buono/a”* in un’ottica “winnicottiana”? Mi viene in mente questo video che fa riflettere sul ruolo dei care-giver sufficientemente disponibili e affidabili. Tratta di un colloquio proposto per il ruolo definito “il più importante di tutta l’azienda: da direttore operativo”. Guardatelo dura solo 4 minuti e si intitola: “E tu, saresti capace di superare questo colloquio di lavoro?”: https://www.youtube.com/watch?v=34iY4LuzQOY Che ne pensate?
Naturalmente la mia è una provocazione ma credo che un educatore/educatrice dovrebbe essere una persona presente, che sa esserci anche nell’assenza di un turno, delle ferie e che al bisogno sa separarsi. Una persona preparata, che conosce lo sviluppo del bambino, le crisi evolutive con i suoi segnali di disagio prevedibili e transitori. Che sappia cogliere quelli più rigidi che necessitano di maggiore attenzione e che potrebbero parlare di una storia traumatica. Una persona che in modo professionale e guidato dalla competenza (e non da emergenze/urgenze emotive) tenda ad ampliare la “finestra di tolleranza emotiva” dei bambini con costanza, continuità e professionalità oculata (Fisher, 2017). Una persona che rinforza la parte del Sé non abusata dei bambini, la parte di Sé che va avanti con la vita normale (nella scuola, con i pari, nelle gite, nelle passioni…) cogliendone risorse e curiosità e sa “maneggiare” ed integrarvi quella delusa, che non si fida ed è ferita e arrabbiata dalle ingiustizie e dai traumi subiti. Una persona compassionevole innanzitutto verso sé stessa e verso gli altri, curiosa, non giudicante, che sa perdonarsi e perdonare, coraggiosa e creativa.
Ritengo che nei percorsi di laurea per le professioni educative sia fondamentale l’esperienza della supervisione al tirocinio da parte di docenti universitari preparati a svolgere il compito di preparare alla cura a partire dall’essere loro stessi bravi educatori ed educatrici. Anche dopo, sul campo, formazione e supervisione costanti ed obbligatorie sono determinanti nel processo della cura: chi cura (il personale) ha bisogno di essere accolto e curato (dal formatore e dal supervisore). Lo stipendio va riparametrato su livelli più dignitosi. Prendersi cura degli altri con costanza, attenzione, competenza e passione implica studiare, aggiornarsi costantemente, chiedere aiuto laddove non ci si sente adeguati, ottenere crediti di aggiornamento riconosciuti e, al pari di altre professioni di aiuto, dovrebbe significare stipendi medio/alti e con scatti significativi nel tempo. Tutto ciò contrasterebbe il problema del personale introvabile, il rischio di burn out e il turn over tipici di queste professioni con le deleterie ricadute che tali fattori hanno sui bambini e sugli adolescenti accolti in comunità di cui ci dovremmo prendere cura con continuità. Tutto ciò ritengo sia una questione politica, ignorata da troppo e da troppi programmi di governo.
Licia Barrocu, psicologa e psicoterapeuta, docente del Master
- https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/educatori_laurea_si_o_laurea_no_il_dibattito_continua
- https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20220809-educatori-professionali-.html
- https://www.aibi.it/ita/educatori-senza-laurea-fra-polemiche-e-plausi-ma-il-problema-rimane-gli-operatori-di-comunita-non-si-trovano/
Fisher J., Guarire la frammentazione del sé – Come integrare le parti di sé dissociate dal trauma psicologico,
Raffaello Cortina Edit